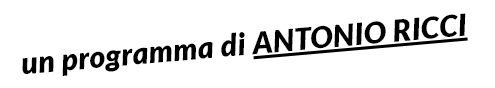Torna Striscia, con la rubrica di Marchi. Intervista a Ricci: Paolo bravo e umano. E la cucina merita questo palcoscenico
Parte la edizione n.33 del programma di Canale 5. Confermato lo spazio “Capolavori italiani in cucina”, si inizia con Cedroni
Parte stasera su Canale 5, solito orario (dal lunedì al sabato alle ore 20,35), la trentatreesima edizione di Striscia la notizia, programma record di longevità mondiale. Quest’anno Striscia sarà “La voce dell’insofferenza”: attualità, inchieste, retroscena, rubriche, parodie per dare voce ai cittadini con l’inconfondibile stile ironico e provocatorio. «L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni – spiega Antonio Ricci, che il programma ha creato e firma da sempre – Insofferenza per la mascherina, insofferenza per il distanziamento, insofferenza per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale e sciolta e ora non è più possibile».
Saranno Ficarra e Picone i primi conduttori al bancone del programma; saranno seguiti a dicembre da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che a loro volta passeranno il testimone a inizio marzo alla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Chiuderanno la stagione Michelle Hunziker e Gerry Scotti.
Alcuni volti nuovi e tante conferme all’interno del programma. Tra queste ultime, la rubrica Capolavori italiani in cucina, che vede come protagonista Paolo Marchi alle prese con i piatti icona di grandi chef. Prima messa in onda domani, martedì 29 settembre: ci sarà Moreno Cedroni che racconterà… Appuntamento su Canale 5!
Antonio Ricci, arriva la trentatreesima edizione di Striscia la notizia. E torna anche Capolavori italiani in cucina, la rubrica dedicata alla cucina che ha esordito la scorsa stagione, curata da Paolo Marchi. Quali le ragioni che vi hanno spinto prima a crearla e ora a riproporla?
«C’è una parte destruens in Striscia, molto forte: denunciamo scandali, sprechi, disastri ambientali, truffe. Ce n’è un’altra altrettanto forte, costruens: non vogliamo dare solo notizie che ti fanno star male, ma anche quelle positive. Abbiamo sempre fornito appoggio alle associazioni impegnate a curare il territorio, agli artigiani, insomma alla “parte debole” che noi vorremmo diventasse più forte. C’è Davide Rampello che va in giro a cercare le eccellenze del gusto; sosteniamo Slow Food, oppure il Fai; avevamo Philippe Daverio (un grande che purtroppo ora è mancato) che andava a spiegare i musei gratis, insomma tutta la bellezza d’Italia alla quale è possibile usufruire senza nemmeno pagare un biglietto… Tante eccellenze. Dato che una di queste è la cucina, era giusto che ce ne occupassimo, attraverso Paolo Marchi, il nostro omaccione (ride). È un settore vivo, che crea bellezza e benessere. Siamo, insomma, perfettamente all’interno del disegno, dell’ordito che caratterizza Striscia».
Dal punto di vista televisivo, perché Capolavori italiani in cucina funziona? Quali sono gli elementi che la rendono riconoscibile e quindi godibile?
«Innanzitutto c’è lui, Paolo, riconosciuto e autorevole. Non è un classico personaggio televisivo, non ne ha la tracotanza e la sicumera. Il suo modo di porsi non è quello del professore o del critico algido, stile Anton Ego di Ratatouille; avviene piuttosto una sorta di immedesimazione con lui, risulta simpatico, quasi un pelouche golosastro: ciò lo rende umano, vicino. Le cose che dice arrivano nella maniera giusta perché non cadono ex cathedra; si vede invece che è coinvolto, che ha l’acquolina, sembra quasi nella caverna di Alì Babà, vorrebbe subito passare all’assaggio, si trattiene a stento. E infatti poi, con un gioco, lo facciamo finire direttamente nel piatto!».
Qual è il suo Capolavoro italiano in cucina preferito?
«Da buon ligure dico le picagge (una pasta con farina di castagne) col pesto, come anche i mandilli de sea (letteralmente “fazzoletti di seta”: simili alle picagge, solo più sottili e con una forma diversa). Altrimenti, essendo anche io un golosone, penso al tiramisù (ne hanno parlato qui, ndr)».
Perché funziona la cucina in televisione?
«In generale ci sono molte trasmissioni quando il costo di produzione è basso. Penso quindi ai talk show politici, che però mettono in scena “piatti” vomitevoli, soprattutto per le facce lombrosiane che li popolano; e poi la cucina, appunto, dove non occorre invitare star, o comici, oppure scrivere testi particolari, perché tutto “parla da sé”. Ora c’è una certa overdose di proposte; c’è eccesso di offerta, quindi si fa indigestione, come a tavola. Ci sarà una selezione. Tutti i fenomeni televisivi hanno il medesimo andamento: un format nuovo va bene, viene clonato all’infinito, si diventa bulimici e alla fine si perdono interesse e scopo».
C’è un programma di cucina che le piace?
«In realtà non li guardo. Ho un po’ seguito solo Masterchef, quando abbiamo fatto una polemica che riguardava la struttura stessa del programma: fanno credere che in competizione ci siano cuochi dilettanti ma in realtà non sono tali, sono già in qualche modo formati, per evitare l’effetto “prosciutto e melone”».
Invero in questi programmi i momenti divertenti sono spesso quando il piatto risulta disastroso, il giudice s’incavola, il concorrente balbetta scuse…
«Sì, ma fa parte del format. È come nella commedia dell’arte: ci deve essere il rabbioso, la vittima, il pasticcione… Sono stilemi che derivano da canovacci classici. Tutte le parti in commedia, e non si sbaglia. Come per il Grande Fratello. Il copione non c’è, ma è come se ci fosse».
Oggi lei è patron della magnifica Villa della Pergola ad Alassio, luogo dell’accoglienza che ospita anche il Nove, ristorante di alta cucina…
«Il nostro chef Giorgio Servetto è molto bravo. Ha solide fondamenta: conosce bene la tradizione ligure, poi sa anche trasformarla in qualcosa di diverso. Ma senza le basi non andrebbe da nessuna parte… Come Picasso: inizi col figurativo, solo dopo puoi passare al cubismo. Meriterebbe una puntata di Capolavori italiani in cucina, per il pesto, o per la sua fenomenale torta pasqualina; c’è però conflitto d’interessi, non è giusto, in questo sono molto rigoroso. Quindi non la faremo».
Cosa le piace in cucina?
«Io sono un mezzo vegetariano, sono contento di Servetto anche perché ha tanto da propormi in questo senso: ricchezza, varietà… Altrove invece mi sento a volte quasi umiliato: chiedo qualcosa di vegetariano e ti servono un piatto da onnivori, cui viene però tolta un’acciuga, tre dadi di guanciale… Vanno di sottrazione! Tu ti senti defraudato, o comunque colpevolizzato».
Ma quali sono gli altri ristoranti del cuore di Antonio Ricci?
«Tanti anni fa, gli studi di Drive In erano in viale Legioni Romane, a Milano, vicino a via Montecuccoli, quindi a Il Luogo di Aimo e Nadia. Praticamente il locale divenne la nostra mensa aziendale. Una vera fortuna! Al venerdì Aimo mi preparava tutta una serie di pacchetti, che portavo a casa: così, per esempio, le mie figlie – allora erano piccole – sono cresciute a suon di pappa al pomodoro di Aimo e Nadia. Non male… Un imprinting importante, non trova?».
Altri indirizzi?
«All’epoca andavo anche al Girarrosto, che ora è chiuso, come altri che frequentavo. Poi a un certo punto sono arrivati i nuovi chef. Andavo – e ci vado ancora – da Cracco, da Berton, dallo stesso Aimo anche nelle sue ulteriori declinazioni, il Vòce e il BistRo… E al Ratanà, e al Trussardi».
Insomma, Antonio Ricci ha un’anima gourmet?
«Frequento buone tavole. Le racconto un episodio, risale a molti anni fa. Insieme alla mia famiglia e a Carlin Petrini, affittai una specie di scuolabus dorato, sembravamo gli Abba in tournée. Destinazione: il ristorante di Michel Bras a Laguiole. Fummo anche fermati in un autogrill da persone che pensavano fossimo un complesso musicale, erano rimaste affascinate dal colore dell’automezzo, stile Priscilla – la regina del deserto, solo meglio tenuto. Diciamo che, più che un gruppo musicale, potevamo essere un’orchestrina».
Le sue figlie (Alessandra la maggiore, Vittoria e poi Francesca la più piccola, oggi manager al Nove) hanno avuto un’educazione al gusto straordinaria…
«Mia moglie cucina molto bene, è anche andata a fare un corso da Ducasse, peccato che da allora non abbia quasi più toccato i fornelli, tranne che durante il lockdown. Quanto alle figlie… Ricordo Vittoria, era ancora piccolina, non andava nemmeno a scuola. Eravamo in viaggio per Roma, ci fermammo alla Locanda dell’Angelo ad Ameglia; mangiammo, tutto ok. Tre anni dopo, stesso percorso: arrivati all’altezza del casello di Ameglia, lei fa: “Scusate, ma qui non è quel posto dove facevano quel buon raviolone?”. (Ride) Altro episodio, riguarda invece Francesca: l’anno scorso andiamo tutti insieme alla Fiera del Bue Grasso, c’era una festa da Chionetti, quello del Barolo, con tanti ristoratori. Un signore s’avvicina: “Ricci, lei è stato ospite da noi, si ricorda? Da Caino! Senta, ma sua figlia, quella bambina… Come sta? Sa che ne parliamo ancora adesso? E le dico il perché: in genere i bimbi sono una scocciatura, dobbiamo preparare loro piatti particolari… Invece sua figlia si spazzolò tutto il menu senza fare una piega!”. Francesca era lì, un po’ cresciuta nel frattempo. Che risate!».
Ultima domanda, invece seria: come può uscire la ristorazione dalla crisi legata al Covid?
«Se ne esce tra un anno. Ma non so chi riuscirà a reggere per tutto questo tempo ancora. Già in tempi normali il margine del fine dining è limitato… Qualcuno dice: quando finirà la pandemia, il mercato sarà ripulito da tanta fuffa. È una visione ottimistica. L’alternativa è che solo fuffa rimanga!».