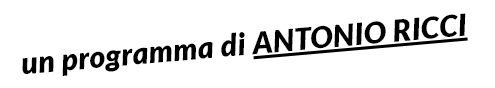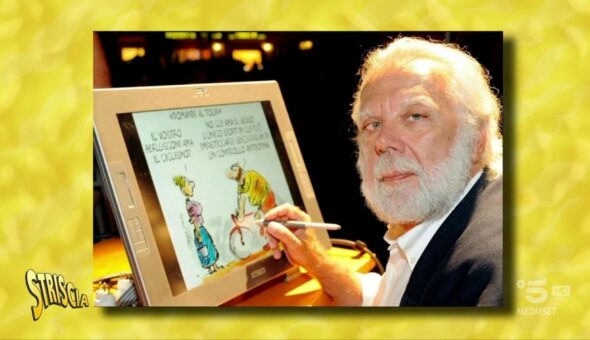IL GRIDO D’ALLARME DEI PUBBLICI ESERCIZI ITALIANI
La politica in questi nove mesi ha sempre sostenuto, ad ogni livello, che fosse necessario il massimo dell’equilibrio tra
la tutela della salute e la salvaguardia dell’economia.
A dispetto di questo principio, il settore della ristorazione, che occupa oltre un milione e trecentomila persone, è stato
il primo ad essere chiuso e l’ultimo ad essere aperto durante il primo lockdown di marzo.
Settantotto giorni di chiusura in cui le nostre imprese hanno tenuto giù le serrande, impedite a servire anche un solo
cliente, mentre questo stesso cliente poteva stare in fila in un supermercato. Un fatto difficile da comprendere sotto
il profilo scientifico, economico, sociale e persino umano.
Con senso di responsabilità, ci siamo preparati a riaprire adottando i rigorosi adempimenti previsti dai Protocolli
Sanitari messi a punto dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e dall’INAIL: distanziamento dei tavoli, registrazione delle
prenotazioni, mascherine, gel igienizzanti, menu digitali, plastificati o monouso, cartelli informativi in ogni angolo dei
locali, prodotti monodose. Abbiamo anche investito sui dehors esterni, consapevoli del fatto che all’aria aperta i clienti
si sentivano più sicuri e tranquilli.
Per quattro mesi abbiamo lavorato in sicurezza. Lo testimoniano i dati dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento
dei contagi e quelli del Ministero dell’Interno sui controlli, secondo cui dall’inizio della pandemia, su oltre 6,5 milioni
di controlli effettuati nel complesso delle attività commerciali, ristorazione compresa, solo lo 0,18% ha subito una
sanzione.
Dopo tutto questo, a quasi otto mesi dal primo lockdown, arriva un nuovo fermo, stavolta a tempo indeterminato.
Ci sfibra l’incertezza e ci demotiva l’instabilità, in un’insensata gara all’untore, e allora vogliamo dire con forza che
noi non siamo il problema. Lo diciamo con il dispiacere che va agli amici e colleghi che hanno chiuso definitivamente
e a quelli che si sono tolti addirittura la vita o hanno perso la voglia di viverla.
Fa rabbia la pretestuosa distinzione tra attività economiche essenziali e non essenziali: tutte le attività economiche
sono essenziali quando producono ricchezza, occupazione, servizi. E tutte le attività sono sicure se garantiscono le
giuste regole e attuano i protocolli sanitari loro assegnati.
Ogni giorno si è disposti ad accettare i rischi sanitari connessi ai milioni di persone che si muovono sui mezzi pubblici,
nelle fabbriche, nei cantieri, nei campi, ma viene ritenuto pericoloso e improponibile frequentare i nostri esercizi,
anche se applicano tutte le misure per il contenimento del contagio.
Da ottobre siamo sottoposti ad uno stillicidio di provvedimenti nazionali, regionali ed in alcuni casi locali: chiusura
alle 24, anzi no alle 23, ancora no alle 22 e poi alle 18 e infine chiusura totale, ma solo nelle zone rosse e arancioni,
dove opera tuttavia l’80% delle nostre imprese con circa 900 mila addetti.
Come se non bastasse, ora arrivano le indiscrezioni sulle chiusure nei giorni di Natale e di S. Stefano. Un fatto che ha
più un valore simbolico che reale per l’economia disastrata delle nostre imprese, ma sul quale non rinunciamo a
dire che sarebbe una misura illogica.
Noi crediamo nel confronto e nel dialogo con le Istituzioni. Ma non vogliamo, ne possiamo assistere inermi a scelte
che sono incomprensibili nei riguardi di un settore letteralmente al collasso.
Vogliamo trasferire il disagio, la preoccupazione, l’amarezza, spesso anche la disperazione che gli operatori di questo
settore stanno vivendo, perché vedono a rischio il futuro loro, delle loro aziende, delle loro famiglie, del loro progetto
di vita, che spesso coincide con il loro ristorante, bar, pub, pizzeria, pasticceria, gelateria, azienda di catering, locale
di intrattenimento.
Siamo imprese anche noi, con i nostri bilanci e i conti da far tornare e nessuno con queste perdite può stare in piedi.
Stare chiusi a dicembre costa al settore ulteriori 6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 27 miliardi già persi. I ristori
erogati sono purtroppo inadeguati e insufficienti a compensare danni così rilevanti ed è, quindi, urgente e vitale
intervenire rafforzandoli, se si vuole evitare la chiusura di oltre 60.000 imprese e la perdita di 300.000 posti di lavoro,
oltre che la dispersione di professionalità, fondamentali per due filiere strategiche per il Paese: Agroalimentare e Turismo.